Mariano Apa
Come entrando ora qui a Grosseto nell’antico a suo modo ottocentesco Vecchio Tribunale, rinnovato di fresco anche nel recente 1999 quale Nuovo Museo, così si entra nell’opera qui proprio in esposizione, di Gianni Antenucci. Quanto sono stratificate le realtà segnico spaziali di Antenucci, così ritornano al presente del nostro visitare, gli occhi e i pensieri dei canonici museali, il senese Chelli ( 1809 / 1869 ) e il grossetano Cappelli ( 1868 / 1939 ); e la trasfigurazione funzionale in questo dell’edificio primario, ovvero del Seminario in cui antecedente si custodivano e la raccolta di Don Giovanni Chelli e le altre ad aggiungersi e ad unificarsi infine ed a ritrovarsi, ora, quale in un felice itinerario del racconto della Maremma e di Grosseto: etrusca, latina, paleocristiana, romanicamente albeggiante sul dirupo della Storia . E con reperti e documenti, insieme al vedersi ecco l’ascolto delle voci e delle preghiere da quell’antico Seminario che ci giungono ancor vive a disegnare le salmodianti attese di un valore e significato che il silenzio del vento di Elia si incaricherà di condurci a noi innanzi. Anche le opere di Antenucci possiedono, nelle loro immagini, voci e ascolti e silenzi e suoni della memoria e dell’inconscio, disegnando archetipi frantumati in un bagno di miele e di saliva. Il giovane di Prato, dove è nato nel 1971, espone le sue pitture digitalizzate su tela e collage con smalti e resine entro plexyglass denominati “Bighiacci” ovvero “Apparati Conservativi” e quindi le acqueforti su carta, le carte politenate a smalto, i cellophane imprimati di pigmenti; ed ancora le dichiarate “Istallazioni Conservative”, dove al plexiglass si sostituisce l’inox , la cassaforte a muro, il polietilene: per raggiungere il movimento del vissuto nella performance, come nella specifica “Vedere Attraverso”, elaborata con la coreografa Laura Marini del Centro per la Danza di Pistoia, nell’ambito del recentissimo 21 marzo di questo 2013 a presentazione delle opere di Antenucci all’Auditorium del pratese Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci. I materiali e la strumentazione frequentata e impiegata da Antenucci delinea una consapevolezza critica del lascito delle Neoavanguardie, dopo i trascorsi di un felice apprendistato nella cultura figurativa e dopo aver praticato con passione emotiva e partecipazione esistenziale – secondo anche lasciti di una cultura dell’Astrattismo e della cultura dell’europeo Informale -- quel che nel 1998 Franco Riccomini, sulla “Nazione” di mercoledì 15 Aprile, definiva essere di Gianni Antenucci “una tavolozza ricca di materia grumosa, di colori cupi come il suo modo di indagare la natura e il tempo. E dove si scoprono proprio quelle orme che siglano e lasciano traccia del cammino dell’uomo”. Le esistenziali “traccia del cammino” rievocano la stagione romana di “Origine” e di “Arti Visive”, da Burri a Scialoja e, costì, taluna pittura fiorentina, come delle ricerche documentate alla “Numero” e alla “Strozzina”, con le esemplarità degli ultimi Conti, Rosai e Venturi, e il di poi di Berti, Guarneri, Nativi, Scatizzi. Ma Gianni Antenucci pur tenendo a mente la epica risalita del secondo Dopoguerra, si plasma su un proprio ripensamento della recente stagione della Postconcettualità che dal di dentro della Neaovanguardia permettono al giovane pratese di recuperare una formulazione ideologicamente minimalista e linguisticamente tautologica della strumentazione artistica. Nella pratica per raggiungere nell’opera l’immagine, Antenucci informa la propria identità culturale e, dunque, la propria matrice stilistico linguistica. Si tratta, in queste opere qui a Grosseto mostrate e datate tra 2010 e 2013, di raffreddare, alla Luna del tema tautologico, il minimalismo dell’opera conclusa per poter raggiungere il Sole di una perpetuata e dall’artista ribadita condizione esistenziale. Così come nel “Teatro della Vita” sbozzata da Ferruccio Ferrazzi a Santa Liberata all’Argentario, o nelle formulazioni informali di Francesco Somaini e Ico Parisi a Santa Maria sull’Osa di Fonte Blanda, per la strada dell’Aurelia che, da vicino Grosseto, conduce a Roma, ed ancora così come al Borgo Carìge a Capalbio, dove nella chiesa avvampa il decoro del ciclo azzurro dipinto da Carlo Vittorio Testi, si mostra in accenno di elenco una pratica dell’arte dove la superficie ci fa sprofondare alla ricerca dell’immagine la quale immagine risalendo dal flusso dell’intero complesso spaziale decorato, impone le icone di un tempo vissuto, declamato: in una rappresentazione del tempo che è fissata iconografia del vissuto esistenziale. Con le tracce di una memoria storica dell’arte che nella pluralità dei contesti culturali decanta la necessità del vissuto esistenziale, ci si può incamminare, dunque, sul sentiero del pur giovane artista di Prato che raccoglie le similari aspettative del vissuto esistenziale da raccontare, dentro la specificità critico estetica della propria condizione di ricerca artistica. Ricerca decantata dalla con testualità dell’eclettismo postconcettuale, di una postmodernità che divaga se pur non dimentica, la oltrepassato comunque stagione della Neoavanguardia. Quello di Antenucci in queste opere che si segnalano dal 2010, sono opere dove presente è un minimalismo non esclusivamente geometrico, che, per tale geometria, si mostra evidente nel manufatto dell’opera posta come sorta di scatola: e si dichiara proprio come quasi contenitore quando l’artista elabora il tema delle “Installazioni Conservative”. Una sottile referenza pervade queste specifiche opere. Desiderate volumetriche, quasi “scolpite”, queste “Conservative” di Antenucci sono evocazioni degli involucri di terracotta e stoffe di Fausto Melotti e dei sogni custoditi negli elaborati di Joseph Cornell : le Shadow Boxes. Le opere in plexiglass risultano di Antenucci un originale felice raggiungimento critico artistico. Egli satina il plexiglass e lo pone sovrapposto alla superficie alla pittura ad olio o ad acrilico su tela – ed eventualmente a collage – sì da costruire/ assemblare i fogli di plexiglass e le tele e le carte, tra di loro a combaciare ma comprendendo una distanza – variabile ad opera, dai cinque ai dieci centimetri - risultando un insieme organizzato nella geometria del formato e nella volumetrica disposizione della sovrapposizione delle pareti così composte. Il meccanismo dell’assemblaggio ricorda la stratificazione delle pellicole di colore e delle velature sulle tele del suo periodo figurativo e astratto-informale. Ma il raffreddamento linguistico concettuale ora conduce Antenucci ad una realtà della stratificazione che è approfondimento per superfici nello spazio. Lo spazio diventa componente determinante a svolgere l’intimità del percorso in opera, il tempo. Antenucci realizza l’opera in quanto costruisce uno spazio – e “costruisce”, quasi si è tentati di dire, per via “architettonica” – in cui si sovrappongono le pareti di lastra impermeabile nella satinatura di una trasparenza che ammorbidendo scava nel colore e nella profondità della superficie elabora la parvenza, ovvero l’idea, ovvero proprio il corpo dell’immagine. L’immagine custodita si rivela in quanto si lascia riconoscere nello scavo ermeneutica all’interno della stratificazione degli elementi. Tale scavo conduce alla verità dell’opera. L’opera è una costruzione spaziale che ospita l’immagine e il corpo dell’immagine si rileva nel procedimento di una ermeneutica del vedere che permette alla memoria di svelarsi: riconoscendo l’elemento che compone la figura dell’immagine. L’immagine dell’opera diventa la figura riconosciuta, così da permettere le letture iconografico/ iconologiche pertinenti. Ma il tutto si racchiude e trova sintesi, nella questione che con le sue opere Antenucci ci impone, nel dover praticare una ermeneutica del vedere per far così risalire dalla stratificazione dei materiali la verità dell’immagine nella evidenza della realtà della figura rappresentata. Così giungendo a concepire l’immagine della verità: il tempo abita lo spazio. Il tempo detta la motivazione al processo ermeneutico che permette la verità della figura. Una figura che non potrà essere decorativismo del racconto, bensì, proprio, si dimostrerà essere immagine del sentimento e del pensiero, realtà di una verità esistenziale che nello spazio è vissuta nel corpo. L’ermeneutica del procedimento con cui si definisce l’immagine realizzata, penetrando la complessa realtà dello spazio per poter risalire nella memoria alla coscienza del proprio tempo, si gratifica nella composizione dell’opera costruita “a strati”. Ma gli strati essendo fogli della satinatura e della trasparenza, così Antenucci ci indica ulteriori – e decisive – referenze. Si tratta, come Bianciardi, di trasferirsi da Grosseto a Milano. Come lo scrittore di “Minatori in Maremma” ( 1956 ), si tratta di affrontare stratificate nebbie e paesaggi di illusioni. Così dobbiamo come entrare dentro i Bianchi e Neri di Ugo Mulas che ancora ci fanno vivere al “Giamaica” del quartiere, oggi irriconoscibile, dell’epica Brera. Quando anche un giovane artista – o un giovane scrittore – dalla Toscana piatta ed etrusca poteva perplesso fermarsi a leggere “Azimuth”, e confrontarsi con le opere di Piero Manzoni, di Enrico Castellani, di Francesco Lo Savio. Soprattutto, in questo 2013 all’Archeologico grossetano, con queste opere di Antenucci, si dovrà fare studio di Lo Savio visto anche al Pecci, in una bella mostra del 1998, e a ricordarsi di Manzoni e Castellani in quella Milano che ospitò il Bianciardi della “Vita Agra” ( 1962 ). E Lo Savio è artista di cui ancora sui cataloghi, torinesi e milanesi, di Germano Celant del 1975 e del 1978, si studia e si medita. La trasparenza diventa luce, e la memoria con cui si fa riaffiorare l’immagine diventa realtà del tempo vissuto. Il lascito costruttivo e concettuale dell’idealismo tautologico di Lo Savio, albeggia dietro la collina di un paesaggio storico critico in cui il giovane di Prato si muove con sentimenti di umiltà e di partecipazione. Dimostrandosi, il giovane artista pratese, attento alle verità del corpo dell’esistenza a cui delega, religiosamente, l’estrema parola del silenzio. In questo senso il percorso di Gianni Antenucci fa intravedere indicazioni ulteriori di sentimenti di religiosità e indicazioni di una spiritualità che nutrendosi alla disciplina della sincerità raccoglie le verità ultimative di questo pellegrinaggio nella esistenza. Le trasparenze della memoria diventano i territori dell’immagine. Amico di Luciano Bianciardi ( 1922 / 1971 ), Floriano Bodini rappresentato negli altrettanto splendidi Bianchi e Neri – dal su citato Mulas -- di Pepi Merisio, ancora ci regala uno sguardo disincantato di decenni a perpetuare l’avventura esistenziale del corpo e del religioso silenzio della preghiera. Bianciardi e Bodini erano lontani dalla cultura della Neoavanguardia, dei Manzoni / Lo Savio e neanche si rispecchiavano nei testi di Villa e di Sanguineti -- lontanissimi, tali citati poeti dell’avanguardia, dalle esperienze di “Mal’aria”, ad esempio -- . Eppure, al di là degli scompartimenti della manualistica, i luoghi diversi nel tempo della storia, le ricerche critico estetiche così diversificate, le differenze culturali e le diversità addirittura linguistico antropologiche, cedono alla unificante pretesa, di poter nominare con l’arte, dunque, un sentimento di religiosità. La religiosità dello Spirito nel colore bianco dell'Annunciazione che si impone nel bellissimo ciclo di affreschi nella parrocchiale di San Michele , nel qui vicino borgo di Paganico. Una spiritualità di colore e musica che coinvolge l'artista. Anche il giovane Antenucci fa intravedere il tema del sentimento di religiosità, stratificando nella materia la luce dell’immagine ermeneuticamente ricondotta alla chiarezza della sua identità, così da giustificare questo vedere che, attraversando le stratificazioni del vivere, risulterà vincente sul nulla in virtù del tutto della verità di una carezza o di uno sguardo capace di ascolto.
Orbetello, Settembre 2013.
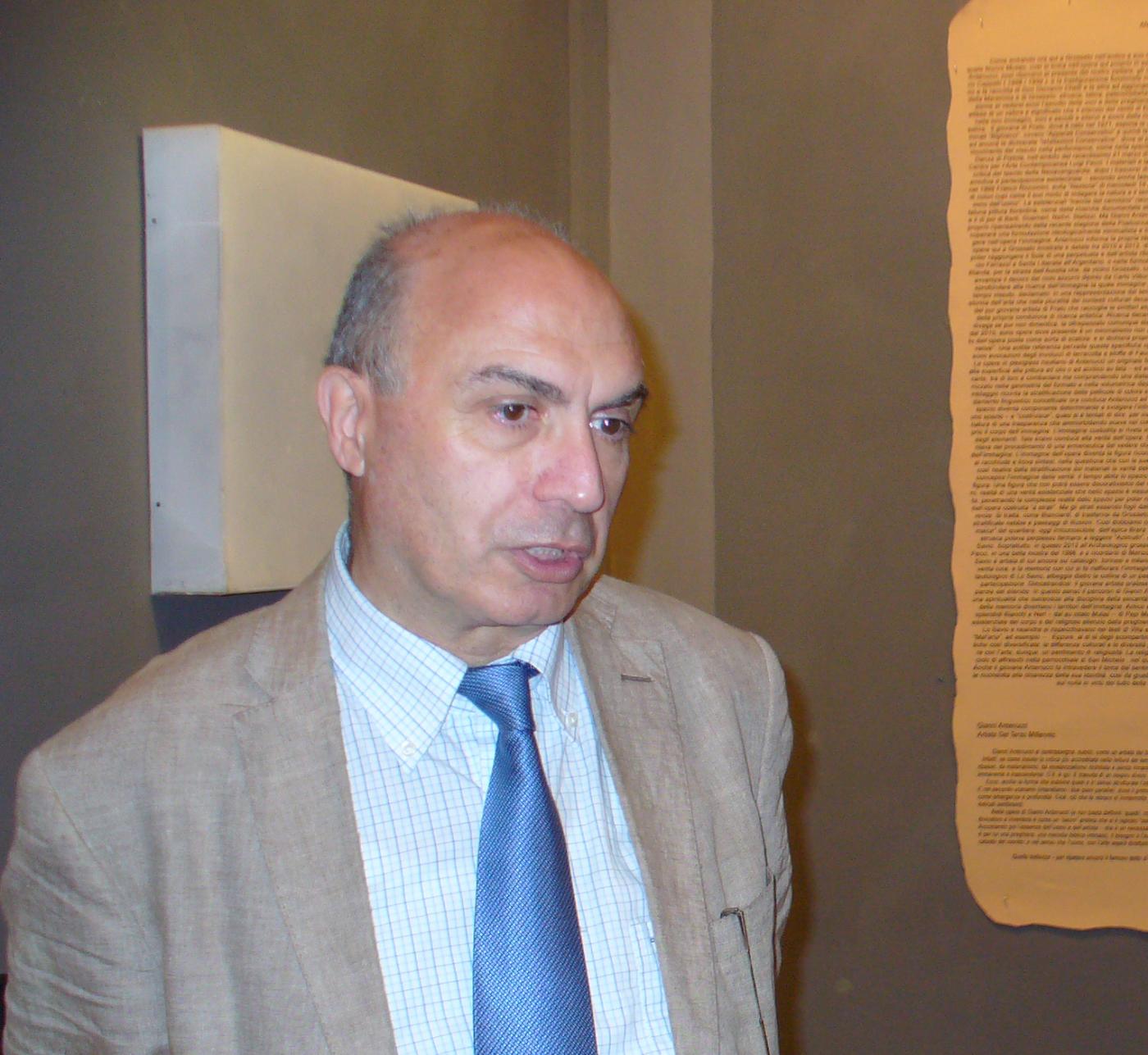






Commenti 0
Inserisci commento